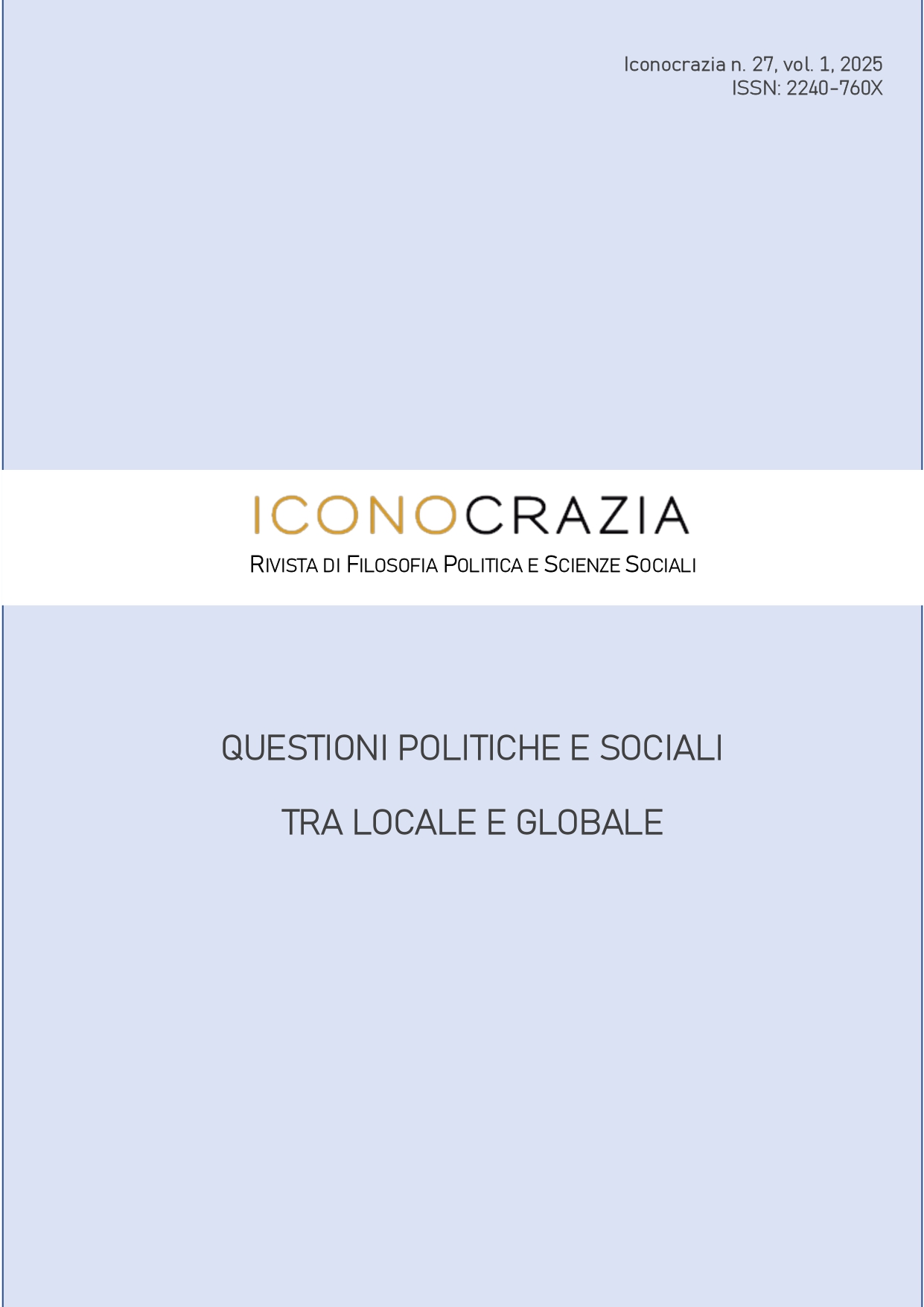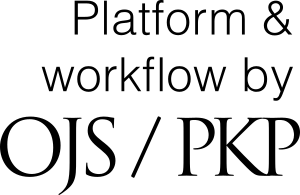La mafia tra Stato parallelo e mimetismo imprenditoriale, capitale sociale e strategie di legittimazione
DOI:
https://doi.org/10.15162/2240-760X/2319Parole chiave:
Mafie, Ordinamenti giuridici, Contrasto, Prevenzione, Mafia, Legal systems, Enforcement, PreventionAbstract
Il presente contributo analizza la mafia nella sua evoluzione contemporanea. Essa ha assunto nel tempo i tratti di un’istituzione parallela allo Stato, fondata su regole interne, apparati sanzionatori e finalità autonome, tali da minacciare in modo strutturale l’ordine democratico. Accanto alla dimensione coercitiva e territoriale, la mafia ha progressivamente sviluppato forme sofisticate di resilienza al contesto economico e normativo. L’ibridazione con il mercato ha dato origine a strategie di mimetismo imprenditoriale che consentono alle organizzazioni mafiose di operare come attori economici apparentemente legittimi, sfruttando lacune regolative, crisi socio-economiche e reti relazionali. In tale contesto, anche l’utilizzo del capitale sociale evolve divenendo strumento che agevola infiltrazione, controllo e legittimazione. La persistenza della mafia e la fenomenologia della sua evoluzione rendono evidente la necessità di affiancare alle tradizionali misure repressive un approccio preventivo, fondato su una comprensione profonda dei presupposti culturali, sociali ed economici che agevolano le complicità tra legale e illegale. La strategia di contrasto passa, quindi, attraverso un approccio capace di integrare strumenti normativi, pratiche di trasparenza amministrativa e responsabilità civile. In questo senso, la promozione di una cultura della legalità, fondata su educazione, responsabilità e partecipazione, si configura come condizione necessaria per sottrarre terreno alla cultura mafiosa e rafforzare la fiducia nei circuiti istituzionali ed economici.
This article examines the contemporary evolution of the mafia. Over time, it has acquired the features of a parallel institution to the State, grounded in internal rules, sanctioning apparatuses, and autonomous purposes that structurally threaten democratic order. Alongside its coercive and territorial dimension, the mafia has progressively developed sophisticated forms of resilience to economic and regulatory contexts. Its hybridization with the market has generated strategies of entrepreneurial mimicry that enable mafia organizations to operate as seemingly legitimate economic actors, exploiting regulatory loopholes, socio-economic crises, and relational networks. Within this framework, the use of social capital has also evolved, becoming a tool that facilitates infiltration, control, and legitimation. The persistence of the mafia and the phenomenology of its evolution underscore the need to complement traditional repressive measures with preventive approaches, grounded in a deep understanding of the cultural, social, and economic preconditions that foster complicity between legality and illegality. The strategy of counteraction thus requires an approach capable of integrating regulatory instruments, practices of administrative transparency, and civic responsibility. In this respect, the promotion of a culture of legality, rooted in education, responsibility, and participation, emerges as a necessary condition for undermining mafia culture and reinforcing trust in institutional and economic systems.
Riferimenti bibliografici
Alfieri A. M. (2022). Lotta alla mafia e cultura della legalità a scuola. Ma una scuola libera ed autonoma, in Portale La Tecnica della scuola – quotidiano della scuola, 12/7/22, consultato il 19/12/24. https://www.tecnicadellascuola.it.
Barberis M. (2011). Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto. Bologna: Il Mulino.
Becker G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, 76 (2), pp. 169–217.
Becker H. S. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. Glencoe: Free Press.
Bobbio N. (1960). Teoria dell’ordinamento giuridico. Torino: Giappichelli.
Borsellino P. (1992). Discorso pubblico presso la Biblioteca Comunale di Palermo, 25 giugno 1992 (https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/Paolo+Borsellino.pdf).
Bourdieu P. (1986). The Forms of Capital, in J. G. Richardson (a cura di), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.
Capograssi G. (1959). Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Id., Opere. Milano: Giuffrè, pp. 183-221.
Catino M. (1997). La mafia come fenomeno organizzativo, Quaderni di Sociologia, 14, pp. 83-98. https://doi.org/10.4000/qds.1533.
Cesarini Sforza W. (2018) [1929]. Il diritto dei privati. Macerata: Quodlibet.
Chiari E. (2024). Che cos’è il maxiprocesso di Palermo e perché è così importante, in Famiglia Cristiana, 22/5/24, consultato il 05/3/24. (https://www.famigliacristiana.it/articolo/che-cos-e-il-maxiprocesso-di-palermo-perche-e-cosi-importante.aspx).
Coleman J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94 (1), pp. 95-120.
Commissione parlamentare antimafia (2018). Relazione conclusiva (XVII Legislatura), Presidenza On. Rosy Bindi. Roma: Camera dei deputati. (https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2018/01/17/24/comunic.htm).
dalla Chiesa N. (2012). L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale. Milano: Novecento Media.
Della Porta D. & Vannucci A. (2012). The Hidden Order of Corruption: An Institutional Approach. Aldershot, UK: Ashgate Publishing.
DiMaggio P. J. & Powell W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, American Sociological Review, 48 (2), pp. 147-160. https://doi.org/10.2307/2095101.
Falcone G. (2017). Io, Falcone, vi spiego cosa è la mafia, in Libertà e giustizia, 22/05/2017, consultato il 10/12/24 (https://www.libertaegiustizia.it/2017/05/23/io-falcone-vi-spiego-cose-la-mafia/).
Falcone M. (2022). Prefazione, in Iapicco M. J. (a cura di), La normativa di contrasto alla “ecomafia”. Quaderni della Fondazione Falcone.
Fiandaca G. & Costantino S. (1994). La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi. Roma-Bari: Laterza.
Fiandaca G. (1995). La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, Il Foro Italiano, pp. 21-28.
Frasca M. (2023). Deontologia giornalistica nell’ambito del processo penale. Dal Maxiprocesso a Cosa Nostra ai 35 anni della riforma processuale del 1988, in L’analisi, 18/05/2023, consultato il 19/12/24 (https://www.pio.latorre.it).
Gambetta D. (1992). La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Torino: Einaudi.
Giannini M. S. (1958). Gli elementi degli ordinamenti giuridici, Rivista trimestrale di diritto pubblico, VIII, pp. 219-240.
Id. (1990). Le relazioni tra gli ordinamenti degli elementi giuridici, Rivista trimestrale di diritto pubblico, IV, pp. 997-1020.
Granovetter M. S. (1973). The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 78 (6), pp. 1360–1380.
Id. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology, 91 (3), pp. 481-510.
Iadeluca F. (a cura di) (2013). Dizionario delle mafie. Roma: Armando Curcio Editore.
Mazzotta M. (2024). Ambiente-contesto e resilienza della leadership nei cambiamenti organizzativi, Iconocrazia, 25 (1), pp. 121-137.
Mosca M. & Villani S. (2010). L’impresa sociale ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati: verso un nuovo modello di sviluppo del Mezzogiorno fondato sul capitale sociale e sul “territorio”, Impresa sociale, 79 (3), pp. 33-50.