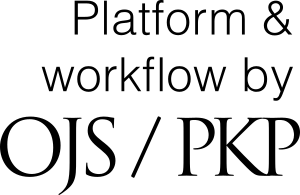«La civiltà moderna non deve esser considerata come una semplice continuazione dell’antica, come un progresso della medesima. Questo è il punto di vista sotto cui e gli scrittori e gli uomini generalmente la sogliono riguardare; e da ciò segue che si considera la civiltà degli Ateniesi e dei Romani nei loro più floridi tempi, come incompleta, e per ogni sua parte inferiore alla nostra. Ma qualunque sia la filiazione che, istoricamente parlando, abbia la civiltà moderna verso l’antica, e l’influenza esercitata da questa sopra quella, massime nel suo nascimento e nei suoi primi sviluppi, logicamente parlando però queste due civiltà, avendo essenziali differenze tra loro, sono, e debbono essere considerate come due civiltà diverse, o vogliamo dire due diverse e distinte specie di civiltà, ambedue realmente complete in se stesse. Sotto questo punto di vista, diviene più che mai utile e interessante il parallelo tra l’una e l’altra». Straordinaria la modernità visionaria con cui, in un pensiero annotato nel marzo 1826 come possibile «preliminare ad una Comparazione degli antichi e dei moderni» (Zibaldone, 4171-4172), Giacomo Leopardi rimarcava le distanze e le alterità oggettive e irriducibili tra passato e presente e bandiva ogni tentazione modernizzante di superficiale identificazione o di sterile attualizzazione. Di fatto, le sue parole legittimano quella visione comparata che sola consente di rileggere le testimonianze antiche alla luce delle domande di senso in esse riposte e di interrogarsi correttamente sul problema dell’incidenza della cultura greco-latina nella realtà odierna, in una parola, della sua ‘classicità’.
I vari ‘Umanesimi’ che, com’è noto, si sono avvicendati nella cultura europea dell’era moderna si sono infatti impegnati a costruire rappresentazioni del passato di volta in volta funzionali alla propria identità, finendo per dare un’immagine variamente deformata del passato, in particolare dell’antichità greco-romana, di cui è stato universalmente riconosciuto il ruolo fondante, e dunque ‘classico’. Ed è altrettanto noto l’esito dell’impiego metaforico dell’aggettivo classicus, che per la prima volta Aulo Gellio (Noctes Atticae, XIX, 8, 15), nel secondo secolo d.C., ha traslato dal lessico della classificazione sociale dei cittadini-soldati alla sfera letteraria, a designare, come attributo di scriptor, quegli autori la cui indiscussa qualità era garantita dalla loro antichità. Tale declinazione ha finito per legittimare, a partire dagli umanisti di fine Quattrocento per arrivare ai giorni nostri, la cristallizzazione di canoni e modelli esemplari in tutti i campi delle lettere, delle scienze e delle arti, innescando processi di selezione ‘classicistica’ legati a una dimensione valutativa e teleologica del passato. Ebbene, a quel continuum discontinuo che è la ‘tradizione’ del mondo classico, e dunque anche agli effetti prismatici e proteiformi delle sue ‘distorsioni’, è dedicato «FuturoClassico»: nella consapevolezza che soltanto ripercorrendo nelle sue luci e nelle sue ombre la dialettica vitalità di quella tradizione il mondo antico può essere percepito culturalmente dall’intera società civile non soltanto come un patrimonio gelosamente coltivato e tutelato nelle ristrette cerchie degli ‘addetti ai lavori’, ma anche come un ‘bene comune’, come una straordinaria eredità storica, gravida di potenzialità preziose ai fini del recupero di radici e identità culturali e dell’elaborazione di categorie critiche idonee a interpretare le domande e le sfide del presente e del futuro.
La sezione "ClassicoDigitale" raccoglie contributi che esplorino i nuovi orizzonti di ricerca che la straordinaria espansione dell'informatica umanistica ha dischiuso nell'ambito degli studi classici. Creare grandi corpora digitali in rete, fruire agevolmente di un'ampia messe di contenuti, rappresentare efficacemente la 'fluidità' di testi documentati da testimoni distanti numerosi secoli dall'originale, operare ricerche mirate - lessicali e semantiche - su estesi archivi testuali, esplorare i testi nel proprio contesto, interrogare gli apparati di varianti e le dinamiche di trasmissione dei testi attraverso i secoli, investigare le diverse forme di memoria poetica riconoscibili nei testi, saggiare le scelte dell'editore, costruire percorsi didattici interdisciplinari, stimolare il confronto della comunità scientifica intorno al medesimo argomento oggetto di studio sono solo alcuni degli obiettivi ora diffusamente perseguibili grazie all'impiego delle risorse digitali e degli strumenti collaborativi per le scienze dell'antichità. Allo scopo di dar vita a un luogo di confronto intorno a questo filone di ricerca, estremamente vitale ma privo al momento di uno spazio dedicato nel panorama delle riviste specialistiche italiane, «FuturoClassico» inaugura una sezione che, intersecando il tema della tradizione e della sopravvivenza, della fortuna e della ricezione della civiltà classica e tardoantica, integra gli obiettivi e i contenuti della rivista.
La ricerca universitaria di ambito umanistico, soprattutto oggi, non può inoltre evidentemente dimenticare la sua funzione di strumento di crescita culturale collettiva e, a questo fine, non può trascurare il collegamento con il mondo della scuola: «FuturoClassico» dedicherà pertanto un’attenzione costante alle ricadute didattiche della nozione di ‘tradizione’ della cultura greco-latina, per fornire maggiore spessore scientifico a una categoria di indubbia valenza pedagogica.
Questa rivista è emanazione del Centro Interuniversitario di Ricerca di ‘Studi sulla Tradizione’ (CIRST), un centro nato nel 2013, sulle orme di un preesistente Centro Interdipartimentale di ‘Studi sulla Tradizione’ dell’Università di Bari, per promuovere l’aggregazione di studiosi dei più disparati ambiti delle Humanities intorno al tema della tradizione e della sopravvivenza, della fortuna e della ricezione della civiltà classica e tardoantica nelle età medievale, umanistico-rinascimentale, moderna e contemporanea. Dopo aver realizzato varie iniziative di respiro internazionale, volte a creare occasioni di dialogo rivelatesi stimolanti e proficue tra le sue diverse ‘anime’, il CIRST, che vede attualmente consociate le Università di Bari, della Repubblica di San Marino e di Padova, ambisce ora, con questa rivista, a dare visibilità ai percorsi di ricerca di tutti gli studiosi, italiani e stranieri, che vogliano confrontarsi sul terreno comune della tradizione del mondo classico: un terreno nel quale le specificità dei propri studi, lungi dall’essere meccanicamente giustapposte, riannodandosi attorno a questo fil rouge trovino un punto d’incontro, intersezione e confronto.
Olimpia Imperio