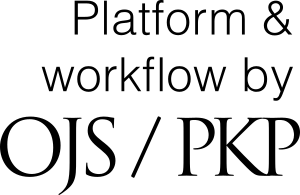Call for papers
Deadlines:
Abstract (500 words): 13th of March 2026 Guidelines submission
Notification of acceptance: 14th of April 2026
Article submission: 30th of June 2026 Guidelines submission
Publication: 30th of November 2026
Length of articles: max 7000 words
To submit an article write to : rivista.echo@uniba.it, vincenzo.susca@univ-montp3.fr
- Cinque sezioni: SAGGI; FOCUS, sezione dedicata ai laureati o ai dottorandi; RECENSIONI; "ECHI DA BABELE";
- Il contributo dovrà essere introdotto da un abstract in inglese (300 parole); Keywords in inglese (5); breve Bio;
- Gli articoli della SAGGI dovranno essere di 6000 massimo 7000 parole bibliografia inclusa, mentre gli articoli per la sezione "Focus" dovranno essere di 15.000-20.000 caratteri spazi inclusi ed inclusa la bibliografia.
- Inoltre, Echo valuterà la pubblicazione di saggi non tematici, da inserire nella sezione "Varie", secondo le modalità dichiarate e le tempistiche richieste per i saggi tematici in questo Cfp.
ECHO – Rivista Interdisciplinare di Comunicazione. Linguaggi, culture, società
CFP numero 8/2026, a cura di Vincenzo Susca e Phillipe Joron
La bellezza e l’artificio.
Arti, estetiche e vita quotidiana nell’immaginario contemporaneo
La bellezza non risiede più – non solo e non tanto – nei luoghi dove il sistema dell’arte l’ha conservata ed esposta, dal Rinascimento al Novecento. Scorre verso altri bacini semantici rispetto a quelli dei musei, delle gallerie e delle accademie. Sgorga da luoghi improbabili, gocciola tra pratiche, scene e corpi periferici riguardo ai centri nevralgici politici e culturali, impregna forme inimmaginabili dall’intellighenzia artistica di stampo classico – dalle borracce alle sneakers passando per le sopracciglia fino agli unicorni, agli NFT e ai gattini del web. Nell’epoca dell’iper-visibilità, della connessione perpetua e dell’estetizzazione diffusa dell’esistenza, la bellezza sembra aver smarrito il proprio luogo d’elezione senza per questo dissolversi. Al contrario, essa migra, si frammenta, si dissemina: trascura le sedi istituzionali che per secoli l’hanno custodita per infiltrarsi nei territori dell’ordinario, nei flussi digitali, nei margini urbani e simbolici, nelle pratiche quotidiane e nei corpi. Non è più un oggetto raro da contemplare a distanza, ma una condizione atmosferica, ubiqua e instabile, che avvolge la vita sociale, la trasforma e la mette in scena. Il prossimo numero di Echo intende interrogare la metamorfosi contemporanea del bello a partire dalla tensione, sempre più evidente, tra arte e artificio, tra esperienza estetica e dispositivi tecnici, tra desiderio di autenticità e proliferazione di simulacri. In un mondo in cui immagini, media, algoritmi e oggetti sembrano sovrastare i soggetti, quale statuto assume oggi la bellezza? Che forma assume l’esperienza estetica quando essa si intreccia con reel, meme, filtri, avatar, piattaforme immersive e intelligenze artificiali generative? Che cosa resta dell’arte e del suo pubblico quando la distinzione tra spettatori e creatori si assottiglia fino a dissolversi, lasciando emergere figure ibride di autorialità diffusa e partecipazione performativa? Lontano tanto da nostalgie restaurative quanto da entusiasmi tecnofili, la pubblicazione esorta sguardi, ricerche e prospettive in grado di addentrarsi nei territori ibridi in cui si gioca il senso del presente estetizzato. Qui il bello non si lascia ridurre a una categoria del gusto né a un semplice ornamento del mondo, ma si configura come campo di battaglia simbolico, come zona di attrito tra euforia e disagio, incanto e perturbazione, sublime e grottesco. In tale prospettiva, l’artificio non è il contrario della verità, bensì una delle sue modalità contemporanee di emersione: una ferita luminosa che espone, svela e insieme disorienta. Le pratiche artistiche, mediali e culturali prese in esame attraversano discipline e linguaggi differenti per restituire la complessità di un paesaggio in cui l’arte non muore, ma si disperde nella vita quotidiana, si ricrea nei gesti minimi, nelle ritualità digitali, nelle estetiche marginali e nei resti. In questa diaspora del bello, la vita stessa, così come il mondo intero, tende a farsi opera, mentre l’opera si trasforma in evento, esperienza, relazione. Lo scopo del numero è dunque esplorare le forme attraverso cui la bellezza, oggi, viene abitata, performata e consumata, senza separare le arti “alte” dalle culture popolari, né i linguaggi istituzionali da quelli emergenti e underground. Saranno particolarmente apprezzati contributi che adottino prospettive transdisciplinari e transmediali, capaci di leggere l’immaginario contemporaneo come un intreccio di pratiche estetiche, dispositivi tecnici e forme di vita. Il numero accoglie contributi teorici ed empirici, di taglio analitico o sperimentale, provenienti da ambiti quali, innanzitutto, la sociologia dell’immaginario, dell’arte e della comunicazione, quindi la mediologia, l’estetica, la storia dell’arte e gli studi culturali, purché orientati a interrogare la bellezza non come valore stabile e mera categoria del gusto, ma in quanto processo instabile e artificiale, ambiente al crocevia tra arte e vita quotidiana.
Scadenze:
Abstract (500 parole): 13 marzo 2026
Notifica di accettazione: 14 aprile 2026
Consegna dell’articolo: 30 giugno 2026
Pubblicazione: 30 novembre 2026
Lunghezza dell’articolo: min 6000, max 7000 parole
Per proporre un articolo scrivere a: rivista.echo@uniba.it, vincenzo.susca@univ-montp3.fr
Bibliografia essenziale di riferimento
Abruzzese A. (1973), Forme estetiche e società di massa. Arte e pubblico nell’età del capitalismo, Marsilio, Venezia, 2001.
Attimonelli C., Estetica del malessere. Il nero, il punk, il teschio nei paesaggi mediatici contemporanei, DeriveApprodi, Roma, 2020.
Baudelaire C. (1863), Il pittore della vita moderna, Mondadori, Milano, 2001.
Baudrillard J. (1981), Simulacri e simulazione, SE, Milano, 1994.
Id. (1996), Il complotto dell’arte, SE, Milano, 2007.
Benjamin W. (1936), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 2000.
Bourriaud N. (2020), Inclusions. Esthétique du capitalocène, PUF, Paris, 2020.
Broch H. (1950), Il kitsch, Abscondita, Milano, 2018.
D’Isa F. (2024), La rivoluzione algoritmica delle immagini. Arte e intelligenza artificiale, Luca Sossella Editore, Roma 2024.
Eco U., a cura di, Storia della bellezza curata da U. Eco, Bompiani, Milano 2004.
Greenberg C. (1939), Avanguardia e kitsch, in Id., L’avventura del modernismo. Antologia critica, Johan & Levi, Milano, 2025.
Groys B., Going public, Sternberg Press, Londra, 2013.
Haraway D. (2016), chthlucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero edizioni, Roma, 2020.
Heidegger M. (1950), L’origine dell’opera d’arte, Marinotti, Milano, 2000.
Joron Ph. (2010), La vita improduttiva. Georges Bataille e l’eterologia sociologica, Rogas, Roma, 2022.
Joselit D. (2012), Dopo l’arte, Postmedia books, Milano, 2015.
Kracauer S. (1963), La massa come ornamento, Prismi, Napoli, 1982.
Lipovetsky G., Serroy J., L’esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, Gallimard, Parigi, 2013.
Maffesoli M. (1990), Nel vuoto delle apparenze. Per un’etica dell’estetica, Edizioni estemporanee, Roma, 2017.
May S. (2019), Carino! Il potere inquietante delle cose adorabili, Luiss University Press, Roma 2021.
Marchesini R., Estetica postumanista, Meltemi, Roma 2019.
Michaud Y. (2003), L’arte allo stato gassoso. Saggio sull’epoca del trionfo dell’estetica, Idea, Roma, 2007.
Moles A. (1977), Psychologie du kitsch. L’art du bonheur, Pocket, Parigi, 2016.
Perniola M., Arte espansa, Einaudi, Torino, 2015.
Susca V., Bello da morire. L’arte e il pubblico dal kitsch al wow, Mimesis, Milano, 2026.
Tanni V., Memestetica. Il settembre eterno dell’arte, Nero edizioni, Roma 2020.
Valeriani L., Performers. Figure del mutamento nell’estetica diffusa, Meltemi, Roma, 2009